i n c i p i t
Violetta
Quando gli avevano detto, al mattino, che la baronessa lo pregava di andare da lei, aveva accolto la notizia con assoluto disinteresse e con un gesto di noia.
- C'è qualcuno malato? - aveva chiesto. Ma la donna che gli aveva recato l'ambasciata non aveva saputo dir altro.
Aveva deciso di non andarci. Ma ora che si era lavato e rivestito, prendeva a considerare la cosa con maggior serenità. In fondo, si diceva, poteva uscire qualcosa da quella visita, e, in ogni caso, sarebbe stata sempre una distrazione.
Questa del diversivo, stava diventando per lui un' ossessione. Da dieci giorni si trovava in quel posto, ma non era ancora riuscito ad abituarsi, e sapeva che non ci sarebbe riuscito mai.
Le giornate di un giovane medico sono lente e tristi da trascorrere in un paese all'antica, di pochi abitanti,. dove l'unico diversivo è di assistere, la domenica, a un pessimo film, e, la sera, di scambiare quattro parole col parroco, col sindaco, col farmacista.
(...)
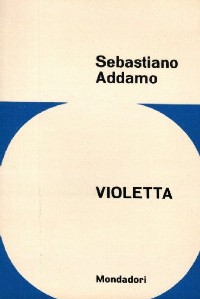
Il giudizio della sera
Il liceo che a Lentini mancava, andai a farlo a Catania. La casa dove venni ad abitare era brutta, scura e umida, su una strada stretta e sporca: un posto triste specie di sera quando vi passavano le prostitute che andavano a passeggiare nei dintorni, e pei gatti che a notte ne facevano il loro regno, orde fameliche e numerosissime che chi sa da dove uscivano e stavano fino all'alba miagolando, raspando ogni mucchio, inseguendosi tra i tetti in perenne reciproca rissa.
Un luogo quasi sordido, me ne avvidi ben presto, con la strada che poi era un vicolo, con il sole che entrava soltanto per qualche ora ed era stentato e sempre debole come s'annoiasse a visitare luoghi del genere; con la stanza dove stagnava un odor di cesso e veniva dalla casa, dalle scale, dallo stesso vicolo, da tutto. il quartiere, era odor di cesso e di piscio di gatto che è più acido e greve del piscio umano, odore di putrefazione e di liquami infetti, odore anche di agglomerati umani, quell'odore che è nauseabondo e repellente per questo: perché nostro ed emanato da noi e intanto contraddicente a quanto catechismo e prediche pasquali e pastorali ci hanno insegnato che noi siamo, noi com'è noto essendo spirito, anima, ragione, tutte cose che non fanno odore; era l'odore di un quartiere che ha odore, poiché ci sono quartieri senza odore, c'erano allora a Catania, asettici, silenziosi, raggomitolati in sé, separati e pignolescamente puliti.
(...)

Un uomo fidato
Quel mattino che era di cielo grigio e plumbeo, Marco Trigillo vide qualcosa che per poco non gli fece inghiottire la biro che teneva nella mano. Quasi non credette ai suoi occhi che per un istante si oscurarono.
Una nube nera passò per il suo volto, veniva dal dentro del suo corpo medesimo, si fuse per un istante col denso velo uniforme delle nuvole accampate sul vetro della grande finestra, poi si distaccò da tutto, parve librarsi e ricadere, e rimase sola, indipendente, autonoma.
E gli parve, dentro quel nero che all'improvviso si insinuassero come dei cristalli lucidi, aghi sottili che lo trapassavano e giungevano fino a lui, fino a quel punto da dove la nube stessa s'era mossa, e una specie di sgomento sorse contemporaneamente a sostituire quelle immagini, qualcosa che rasentava il dubbio, la perplessità e l'angoscia.
« Il tempo, è il tempo, » ebbe modo di dirsi. E non intendeva nulla di preciso, e del resto tutto era vago, terribile e confuso dentro di lui e fuori. Fuori. Nelle strade dove la gente si contorceva spinta da un affanno inquieto e senza precise motivazioni; nelle officine, nelle botteghe, nei cortili, dove frenetica e sorda s'agitava una vita che restava chiusa in sé ed era come se da. un momento all'altro avesse a rompere argini e difese; e come un ululato, una specie d'ululato saliva dai vicoli, dalle case, dalle stesse facce della gente, s'imprimeva ottuso e cieco fra i netti contorni dell'orizzonte.
(...)
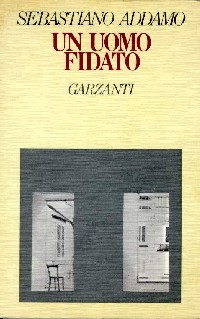
I mandarini calvi
Arrivai che c'era almeno un'ora da aspettare. Me l'avevano detto che ci sarebbe stata folla, cosi mi c'ero recato presto per mettermi in turno. Notai che altri, non molti, già stavano là e parlavano che parevano tranquilli.
Fu l'usciere, uomo energico e ben portante, che mi disse:
«I professori devono aspettare» con la mano m'indicò il luogo: «In sala ».
Entrai. La sala era molto larga ma anche buia, dal balcone arrivava poca luce, forse perché il sole non vi batteva direttamente. C'erano dei divani che correvano lungo le pareti, erano di legno con schienali fatti a liste incrociate come di solito se ne vedono nelle barberie di paese. Andai a sedere vicino agli altri. Intanto mi chiedevo com'è che l'usciere avesse capito chi fossi (essendo la prima volta che mi ci recavo), e uno di quelli, forse rendendosi conto della mia perplessità, mi spiegò con garbato sorriso:
«Ci conosce, l'usciere ».
(...)
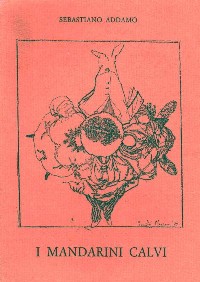
Le abitudini e l'assenza
Mia madre possedeva un piccolo libro del quale ogni tanto scorreva qualche pagina: sottile e nitido di scrittura, con un segnalibro di seta la copertina di pelle verde.
A me piaceva, nascostamente, prenderlo, toccarlo poroso e madido, metterlo in tasca. Più tardi lo estraevo ancora nel calore del mio corpo. Passavo la mano sul dorso, lungo i bordi: erano tiepidi, mi parevano una guancia, una epidermide viva che potesse d'improvviso arrossire. Andavo a riporto di corra, spaventato.
Una volta mia madre s'era chinata a guardare il disegno che stavo, terminando. Era una grande margherita e la coloravo in rosso lacca. Infine prese il foglio tra le mani, lo rigirò variamente, finché si fermò.
Così è più bello, disse.
Era lo stesso, tutte le sue parti uniformi. Ma la luce da cui guardava era diversa; nuovi i segni che, con sorpresa, io scorgevo.
Un'altra volta disegnavo un'aquila. Non ne avevo mai viste, ma io accettavo quel che la Scuola insegna: che la fantasia compensa l'informazione manchevole.
Come modello adoperavo la figura che recava il libro. Ne ignoravo le dimensioni reali, la rapidità acuta del volo, la luce degli occhi. Ma per quanto dell'aquila mi avevano detto, colorai arditamente il disegno: di blu intenso e marino le penne e verdi gli occhi, in rosso acceso il becco e i rostri. Intromisi in ogni parte striature di bianco. Bellissimo, mia madre disse intrattenendosi sul disegno.
Un gallo come mai ne ho visti.
Mia madre veniva spesso a guardare i miei disegni. Non le importava il disegno, ma forse me che disegnavo. Respirava leggermente dietro di me. Mi dava fastidio il suo sguardo che non vedevo, il ritmo del fiato sul mio collo.
Eppure, se d'improvviso era chiamata altrove, con la sua veste che spariva dietro la porta fisicamente avvertivo la violenza del vuoto, una sottrazione di realtà.
Che ogni opera prefigura un destinatario, e il narcisismo le è essenziale.
Dopo una intensa pioggia si formava nella strada sottostante, di faccia alla finestra, una pozzanghera profonda. Le era sempre piaciuto lanciarvi dei sassolini, creare quei cerchi lenti e mobili che poi , stava guardare, perduta chi sa in che cosa.
Se veniva sorpresa si allontanava rapidamente dalla finestra, e forse arrossiva. Mormorava che dava un po' di molliche agli uccelli.
Poverini, diceva, non hanno nulla.
Senza parlare le porgevo lo stesso libro aperto sulla medesima pagina. Recava una breve storia di dolore e di giustizia.
(...)
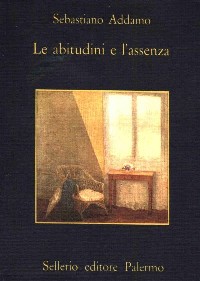
Palinsesti borghesi
Anche quel giorno il signor Favilla sporgendosi come le altre volte dal ballatoio, attese lo sguardo dell'usciere. Allora chiuse la porta e cominciò a scendere le scale.
L'ufficio, pur facendo parte della Direzione del Registro, ne restava per cosi dire fisicamente fuori, ubicato com'era fra l'atrio e i piani superiori. In comune avevano il grande atrio dell'ingresso e naturalmente gli uscieri e il portiere. Si trattava di un unico vano di due metri per tre, appena sufficiente per un tavolo, la sedia e lo scaffale, con un'inutile finestra in alto che non faceva luce adeguata e tra l'altro munita di vetri fissi rafforzati da due robuste sbarre in ferro. L'apparenza era di cella e nelle intenzioni del costruttore un ripostiglio; le esigenze del servizio lo avevano trasformato nell'ufficio del protocollo.
Per il signor Favilla il positivo della situazione stava che li non andava mai nessuno eccetto qualche usciere e qualche collega, sebbene i lati negativi fossero notevoli e nascevano dall'ufficio medesimo, caldissimo d'estate e freddissimo d'inverno. Quando arrivavano luglio e agosto che pareva lasciassero cadere il caldo a pezzi, il locale diveniva una bolgia: ogni cosa pareva di fuoco, l'aria era densa, irrespirabile, immobile.
(...)
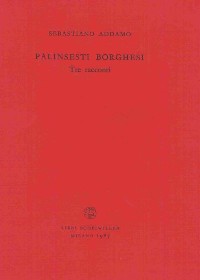
Piccoli dei
IL PROFESSORE MURGIO
È già notte e lui si ritrova nella sua stanza. Non sapeva che fare. Una impotenza da nevrosi, ghigna. Tutto gli sembrava inutile di quanto fino ad allora aveva fatto. Del resto, quello che aveva fatto era di leggere libri. E ora si trovava in un silenzio da giudizio universale. "La scienza moltiplica gli affanni", pensò con ironia. Il vecchio Ecclesiaste aveva ragione, ma la ragione era ridicola.
Eppure non si trattava di questo. La felicità è una parola umana, questo lo sapeva e non l'aveva mai cercata. È che qualcosa s'era rovinata, dentro di lui; un errore c'era pur stato, e non sapeva trovarlo.
Dalla sua finestra scorgeva i palazzi di fronte, qualche balcone di tanto in tanto si illuminava, qualche altro si spegneva. Era vita che correva su quei pavimenti che neppure vedeva. Uomini e donne che vivevano. La luna vibrava nel suo moto immenso e perenne, in quel silenzio s'agitava l'eterno spirito della fecondità. Tutto era in ordine. Le ruote sono ferme, le officine operose del mattino sono inerti, tutto è secondo il suo ordine. L'opera del giorno diventa il silenzio della notte.
Avrebbe potuto uscire, camminare sulla terra, sentirsene parte; sentirsi parte degli uomini. Non era capace.
La testa gli fa male. Forse si è appisolato, s'è risvegliato con una specie di intontimento che rasenta il dolore. Un deserto. Un vuoto senza dimensioni.
(...)
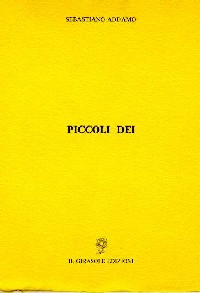
Non si fa mai giorno
La mano tagliata
1. Pensava vuotamente, cioè senza oggetti precisi. Stranamente, un cane abbaiò.
Si guardò intorno nella stanza. La stanza illuminata rifletteva la quantità e diversità di oggetti che si possono trovare in una stanza, i libri coi dorsi di vario colore, i ninnoli, i quadri alle pareti uno dei quali raffigurava una civetta che il pittore aveva rappresentato con gli occhi rossi, i vetri che a loro volta rimandavano e deformavano le immagini, gli alari del camino che assumevano fogge di mostri in agguato nel groviglio dei loro disegni, il lampadario con i cristalli sfaccettati e tintinnanti sotto il vento, le sfumature del tappeto. Indescrivibile la molteplice quantità di sensazioni che emanano gli oggetti.
L'abbaio del cane aveva spezzato l'arco del silenzio. E anche quando fu cessato, l'arco rimase incrinato, come una cosa che se ne va per sempre.
Guardava meditabondo. Fuori, oltre i vetri, c'era la notte.
È possibile che alcune immagini banali e casuali, si possano legare d'improvviso alle profondità dell'esistenza?
(...)

| biografia | | bibliografia | | recensioni | |cenni bibliografici| | farfalle| | il giro della vite| | le linee della mano | | a Vera e Cetti | | la metafora dietro a noi | | alternativa di memoria | | il bel verbale | | Leonardo e i suoi amici | |copertine| | premi | | premio Moravia | | delle difficoltà ... | | intervista |